“Quello che stiamo per assistere è tratto da fatti reali, avvenuti a Brooklyn, New York, il 22 agosto del 1972”.
La frase che apre Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet mette subito le cose in chiaro: si sta per raccontare una storia vera, e questo rende ancora più folle lo svolgersi della trama.
Siamo a Brooklyn, appunto, negli anni ’70: le persone che la abitano appartengono a diversi ceti sociali, con differenze culturali ed economiche, un’eterogeneità evidente in procinto di evolversi sempre di più, mentre il Sogno Americano sembra ormai un’illusione, che lascia spazio alla disillusione giovanile. Sono gli anni della feroce e spietata guerra in Vietnam e dei molti errori fatti e ripetuti dai politici di quegli anni.
Tre disadattati, emarginati e nevrotici, escono da una macchina ed entrano in una banca per una rapina. Il loro obiettivo è prendere i soldi e fuggire, senza far del male a nessuno. Si sono dati mezz’ora come tempo massimo. Il piano, però, parte subito male: all’ultimo, il più giovane di loro si ritira, e da tre ne rimangono solo due: Sonny e Sal. Sono giovani e inesperti, si muovono con una goffaggine quasi comica.
Il primo si avvicina al direttore e, con un gesto deciso, gli punta contro un’arma da fuoco. Il secondo va verso una cassiera, con in mano una scatola per fiori contenente un fucile. È più impacciato, e con una fatica imbarazzante smonta il porta fiori tirando fuori l’arma, e scatenando il panico. Peccato che, in meno di dieci minuti e per una serie di motivi, la rapina fallisce: con loro sommo e sgradito stupore, i due ladri scoprono che i soldi nella cassaforte sono pochissimi.
Subito dopo, una telefonata li avvisa che la banca è già circondata dalla polizia. Per sopravvivere, i due decidono di rimanere all’interno dell’edificio e prendere tutti in ostaggio: il direttore, la guardia di sicurezza e le commesse (tutte donne). La vicenda diventa immediatamente un caso di cronaca nera. Le lunghe trattative tra i rapinatori e le Forze dell’Ordine attirano sempre più l’attenzione del pubblico (che parteggia per i rapinatori) e, naturalmente, dei mass media, che sono il secondo, se non il vero, protagonista della vicenda.
Di punto in bianco, la vita privata dei due giovani diventa di dominio pubblico, e presto si viene a sapere che Sonny ha una moglie, oltre che un compagno transgender (Chris Sarandon). Subito la TV distorce l’informazione, definendo anche Sal come omosessuale. Tuttavia, agli occhi dell’opinione pubblica, i rapinatori diventano presto degli eroi: Sonny cerca di dettare condizioni alla polizia, incita la folla alla ribellione al grido di «Attica, Attica», e gli stessi ostaggi, specialmente le donne, finiscono quasi per tifare per loro.

Per ottenere questo mix di documento, finzione ed emozioni, Lumet scelse la strada dell’improvvisazione, cercando di carpire gli stati d’animo dei suoi attori. In primo luogo da Pacino, a tratti debordante, ma sempre teso e vibrante. Il film nonostante le 6 nominations, vinse una sola statuetta, quello per la Miglior sceneggiatura.
Rimane comunque nell’immaginario di tanti l’interpretazione dell’immenso Al Pacino, che ci ha regalato un Sonny a tratti imbranato, ma anche coraggioso, innamorato e protettivo, passionale ed impaurito. Un Sonny che non abbandona mai l’insicurezza nello sguardo, ma continua a gridare per far sentire la sua voce. Un Sonny che non ha paura di parlare chiaramente col capo della polizia, ma che ne vede l’umanità. Un Sonny ingenuo, che vuole dimostrare di avere fegato e cerca, al di là delle sue problematiche personali, di parlare per tutti, per tutti quelli che non hanno voce.

Questo film è un pezzo di storia del cinema, da rivedere, per commuoversi, per arrabbiarsi, per perdersi nella maestosità della recitazione di uno dei più grandi attori viventi.
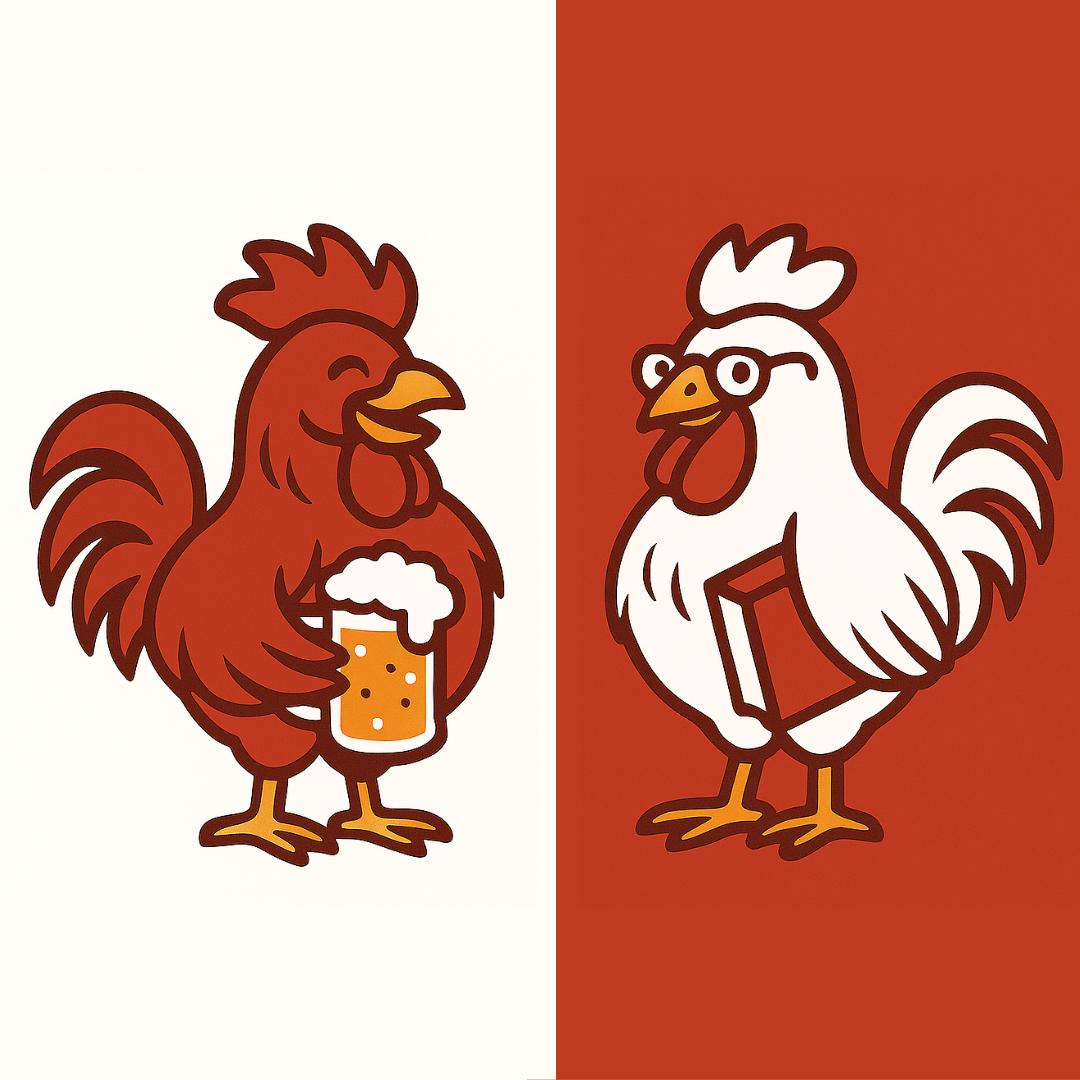





Lascia un commento